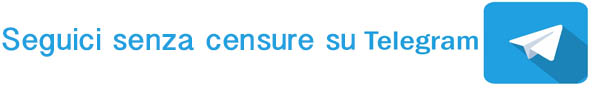Il 16 luglio 1945, alle 5:29 (ora locale), gli Stati Uniti fecero esplodere nel deserto di Jornada del Muerto, a 56 chilometri dalla città di Alamogordo nel Nuovo Messico, la prima bomba nucleare, chiamata Trinity , che faceva parte del progetto Manhattan. Con questo test iniziò l’era atomica. Venti giorni dopo, le due bombe successive furono sganciate sulla popolazione civile giapponese a Hiroshima e Nagasaki, ponendo fine alla seconda guerra mondiale.
Da allora, gli Stati Uniti hanno fatto esplodere altre 1.129 bombe fino al 1992 come parte dei loro test nucleari. A loro si aggiungono l’ex Unione Sovietica con 981, Francia (217), Regno Unito (88), Cina (48), India (6), Pakistan (6) e Corea del Nord (6), di cui si è svolto l’ultimo test nucleare nel settembre 2017.
In totale, negli ultimi decenni sono state testate quasi 2.500 bombe nucleari, fornendo un’energia totale di oltre 540 megatoni sulla Terra. Le bombe sganciate nell’atmosfera da sole rappresentavano 428 megatoni, l’equivalente di oltre 29.000 bombe delle dimensioni di quella di Hiroshima, che alla fine del 1945 aveva causato 166.000 morti.
Impatto ambientale devastante dei test nucleari
Considerati necessari per misurare la sicurezza, l’efficacia e la potenza delle armi nucleari, i test sono stati condotti in vari tipi di ambienti, in parti remote del mondo e lontane dalla civiltà. L’obiettivo era quello di evitare di nuocere alle persone, che a lungo andare potrebbero soffrire di lesioni cutanee, avvelenamenti o vari tipi di cancro, per effetto delle radiazioni.
Nell’atmosfera, il sottosuolo e l’acqua sono stati principalmente i luoghi scelti e sono stati utilizzati diversi metodi per lanciarli: a bordo di chiatte, in cima a torri, da aeroplani, sospesi a palloni, con razzi, sulla superficie della Terra o più di 600 metri sott’acqua e più di 200 metri sottoterra.
Tuttavia, sebbene non ci fossero preoccupazioni nei primi anni delle prove, diversi eventi e prove hanno iniziato a dimostrare che questi test hanno influenzato l’ambiente e le persone. A causa delle crescenti minacce ambientali come la ricaduta radioattiva – la deposizione di una miscela di particelle dall’atmosfera da un’esplosione – o l’inquinamento, l’Organizzazione delle Nazioni Unite celebra ogni 29 agosto, dal 2010, la Giornata internazionale contro Test nucleari.
“Il grave danno ambientale causato da questi test nucleari, i più potenti mai condotti nell’atmosfera, così come il contesto generale dei test globali sulle armi nucleari, hanno posto le basi per la prima cooperazione internazionale su larga scala per eliminarli”, afferma il Ricercatore presso l’Università di Bucarest in Romania, Remus Prăvălie, in un articolo pubblicato sulla rivista Ambio .
In effetti, l’ONU ha già mostrato negli anni precedenti – come mostra questa risoluzione dell’Assemblea generale del 2000 – la sua preoccupazione per gli effetti dannosi per “le generazioni presenti e future dei livelli di radiazione a cui l’umanità e l’ambiente erano esposti con questi test ”.
LEGGI ANCHE:
Perchè i test nucleari francesi sono crimini contro l’umanità
Bombe atomiche, rivelazione choc: secondo Hans Kristensen gli Usa ne conservano 40 in Italia
Aggiornamento sugli “stress-test” nucleari in UE
Fukushima: “L’acqua radioattiva buttiamola in mare”
Verso il divieto dei processi
Una delle prime conseguenze dei test fu osservata nel 1954 con la bomba Castle Bravo , fatta esplodere nell’atollo di Bikini, nelle Isole Marshall nell’Oceano Pacifico. L’esplosione ha triplicato accidentalmente la prestazione stimata nel suo progetto, raggiungendo i 15 megatoni, la potenza più alta mai registrata dagli Stati Uniti. Era mille volte maggiore di ciascuna delle due bombe sganciate in Giappone, ma inferiore alla potenza del bomba più grande della storia: la bomba dello zar (dell’Unione Sovietica), circa 50 megatoni.

La detonazione è avvenuta a sette metri sopra la superficie del suolo e ha causato un cratere di due chilometri di diametro e 70 metri di profondità e un fungo atomico che ha raggiunto i 14 chilometri di altitudine e sette chilometri di diametro in un minuto. A 10 minuti, la nuvola ha superato i 40 km di altitudine e 100 km di diametro, espandendosi a più di 100 metri al secondo.
La catastrofe, la più grande negli Stati Uniti, ha generato una ricaduta radioattiva con corallo polverizzato che si è diffuso nel resto delle isole dell’arcipelago e si è abbattuto, più pesante sotto forma di cenere bianca, sui residenti e sui militari. Una pioggia più particolata e gassosa ha raggiunto il resto del mondo fino ad arrivare in Australia, India e Giappone, anche negli USA e in parte dell’Europa. In totale, l’inquinamento ha interessato direttamente un’area di circa 18.000 km 2 dell’Oceano Pacifico.
All’indomani dell’esplosione, non ci volle molto perché si sentissero reazioni internazionali contro i test termonucleari atmosferici, di cui 500 sono stati lanciati finora, secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC, per il suo acronimo in inglese). Tutto ciò culminò nel 1963 con la ratifica del Trattato per la proibizione parziale dei test nucleari, a cui la Corea del Nord non avrebbe mai partecipato – Francia e Cina si unirono anni dopo.
Secondo un’indagine del centro americano, ancora oggi la ricaduta radioattiva è presente in piccole quantità in tutto il mondo, e infatti chiunque sia nato dopo il 1951 negli Stati Uniti ha ricevuto un qualche tipo di esposizione alle radiazioni da questo fenomeno legato a test sulle armi nucleari. Figuriamoci cosa è successo come ricaduta mondiale dopo il disastro di Fukushima, sia per l’inquinamento dell’aria che per quello dell’acqua degli oceani.
Fukushima: cosa accade 8 anni dopo
Come sono cambiate le nuvole
Il periodo radioattivo dopo i test ha causato altre alterazioni nell’atmosfera, come i cambiamenti nei modelli di precipitazione. Un lavoro, recentemente pubblicato sulla rivista Physical Review Letters , suggerisce che i test effettuati principalmente tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso da Stati Uniti e Unione Sovietica sono stati in grado di produrre effetti in nuvole anche a migliaia di chilometri di distanza dai siti di detonazione.
I fisici britannici, guidati da Gilles Harrison, del Dipartimento di meteorologia dell’Università di Reading, nel Regno Unito, hanno utilizzato documenti storici tra gli anni 1962 e 1964 da una stazione di ricerca situata in Scozia per confrontare i giorni con carico radioattivo basso e alto.
I risultati mostrano che le nuvole erano visibilmente più dense e più spesse e c’era in media il 24% in più di pioggia nei giorni con la maggiore radioattività.
“Gli scienziati dell’epoca impararono a conoscere i modelli di circolazione atmosferica studiando la radioattività rilasciata dai test nucleari della Guerra Fredda. Ora, abbiamo riutilizzato quei dati per esaminare l’effetto sulle precipitazioni “, afferma Harrison, professore di fisica atmosferica all’università britannica.
La corsa al nucleare negli anni successivi alla seconda guerra mondiale ha così permesso ai ricercatori di studiare come la carica elettrica – rilasciata dalla ionizzazione dell’aria dovuta alla radioattività – influenzi la pioggia. Fino ad ora, si pensava che il primo modificasse il modo in cui le gocce d’acqua nelle nuvole si scontrano e si combinano, alterandone le dimensioni e influenzando la pioggia.
Antiche registrazioni meteorologiche hanno permesso di risolvere parte di questa ipotesi, soprattutto considerando che i dati provengono da stazioni situate nei pressi di Londra e nelle Isole Shetland, nel Nord Atlantico, circa 480 km a nord-ovest della Scozia, poco interessate da inquinamento antropico. “Questo lo ha reso un posto molto migliore per osservare gli effetti della pioggia”, notano gli autori.
Sebbene le esplosioni di prova abbiano caricato l’atmosfera di tutto il mondo di radioattività, dalla metà degli anni ’90 la comunità internazionale ha unito le forze per raggiungere un divieto totale con un nuovo trattato, attualmente firmato da 184 paesi e ratificato da 168. Ora, in attesa che potenze nucleari come India, Corea del Nord e Pakistan lo approvino, non resta che attendere l’entrata in vigore dell’accordo, chiudendo un occhio o entrambi sulla cronica incapacità dell’uomo di evolvere da se stesso.
Di Adeline Marcos
Ecoportal.net